La generazione delle cadute
La generazione di coloro che oggi hanno tra i 30 ed i 45 anni, della quale io faccio parte, potrebbe essere ricordata un domani come la generazione delle cadute.
Sono sempre stato dell’idea che il motto “si stava meglio quando si stava peggio” abbia poco senso, se non nella sua accezione di analogia con il detto popolare per cui l’erba del vicino è sempre più verde. In realtà, come è abbastanza ovvio, ogni periodo storico ha le sue croci e le sue delizie. Poi, per carità, i distinguo esisteranno sempre. Ci sono anni in cui le delizie sono tali da superare le fatiche delle croci; ed altri in cui le croci sono così pesanti, da far appassire i profumi delle delizie. Senza contare che le inclinazioni caratteriali, del tutto individuali, possono attribuire coefficienti diversi a meraviglie e disgrazie.
I nostri nonni hanno vissuto le croci delle guerre (spesso entrambe) e, se fortunati, hanno goduto dell’euforia propria delle rinascite.
Quanto ai nostri genitori, solo qualcuno, nel momento in cui veniva alla luce, è stato sfiorato dalla consapevolezza del crocevia storico dell’immediato dopoguerra. Tutti, invece, hanno attraversato, con più o meno trasporto emotivo e fattiva partecipazione agli eventi, gli anni delle rivoluzioni culturali, ed, al contempo, dell’espansione economica. A prima vista verrebbe da dire che questa generazione è stata particolarmente favorita dalla sorte, avendo avuto abbondanza di che nutrirsi sia materialmente, sia spiritualmente. Probabilmente la bilancia di chi ha vissuto quegli anni pende maggiormente verso le fortune, eppure non dubito che sia stata un’epoca densa di fatiche e sofferenze, almeno per chi l’ha vissuta (magari meno per chi da quei momenti si è lasciato attraversare). Anni di smarrimento di certezze granitiche, come la solidità del nucleo famigliare, e di scelte e posizioni con cui dialogare ed entrare in contrasto con la propria coscienza, oltre a nuovi modelli da abbracciare e cucirsi addosso su misura, nell’affermazione del proprio io individuale e nell’educazione dei figli.
La nostra generazione è stata segnata, invece, da una infanzia mediamente comoda. Progressivamente i figli hanno acquisito più diritti, liberandosi nello stesso tempo da tante imposizioni. E, generalizzando sia chiaro, non si discosta troppo dalla realtà sostenere che i sacrifici siano stati esigui, soprattutto se paragonati alle possibilità di maneggiare il superfluo, tante volte probabilmente senza riuscire a coglierne appieno il valore. Di contro, con l’emancipazione femminile e la progressiva dilatazione del momento dedicato alle professioni dai nostri genitori, una grande privazione senz’altro l’abbiamo subita: quella del tempo trascorso in loro compagnia, per lo meno in termini quantitativi (pur se risulta difficile pensare che non vi siano state implicazioni dal punto di vista qualitativo).
Non è stato e non è inusuale, come un marchio stampato in fronte, essere catalogati come “viziati” (o “bamboccioni”). Non mi è del tutto trasparente se il termine, che in verità suona innegabilmente come un giudizio poco lusinghiero, sia a tutti gli effetti rivolto nei nostri confronti, o non sia invece un rammarico di chi lo pronuncia riguardo il proprio stile educativo adottato verso i figli, e il modello di società che ha contribuito ad affermare negli anni. Mi è abbastanza chiaro, invece, che tale aggettivo, una volta svuotato della sua connotazione in termini di valutazione, sia, seppure grossolanamente, calzante. Oggi più che mai, sgomitando nel globalizzato mondo del lavoro, fianco a fianco con persone di paesi emergenti che hanno dovuto guadagnarsi istruzione e competenze, ne percepiamo il significato, ogni volta che ci rendiamo conto di trovarci a dover dividere, o contendere, un posto nella società. Al quale noi siamo arrivati magari con merito, dedizione e convinzione, ma quasi sempre camminando sorseggiando una granita; mentre il nostro nuovo prossimo, per essere lì al nostro fianco, ha divorato la strada consumandosi le scarpe e salendo scale a tre gradini per volta. Il fattore “grinta”, insomma, difficilmente può giocare in nostro favore. Tra quindici o trent’anni per la nostra progenie sarà ancora più dura, e non sarebbe un gran male se ogni tanto ce lo ricordassimo.
La nostra generazione è la generazione delle cadute. La caduta del muro di Berlino, la fine dell’utopia comunista. La caduta non solo simbolica dei confini, con la libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone, la nascita della globalizzazione, e dei nuovi rapporti di integrazione tra i popoli (talvolta conflittuali). La caduta di tante convenzioni, di troppi ideali.
Oggi, qualcuno comincia a sussurrarlo (pur senza esporsi ai quattro venti), siamo ad un passo dall’ennesima caduta. Quella del capitalismo occidentale espresso ad oggi, del mercato libero, che di libero ha avuto poco ed ha sempre meno, manovrato e controllato da potenti più o meno noti. In tutto l’occidente il divario sociale è sempre più ampio, la disoccupazione pressante, l’inefficienza degli apparati statali e sovrastatali sempre più evidente. Il livello dei debiti pubblici ha ormai raggiunto pesi insostenibili. Qualche economista propone soluzioni aggressive, con imposizioni fiscali capaci di ridurlo, alle quali dovrebbero poi seguire politiche espansionistiche per recuperare la crescita economica e conseguentemente il gettito. Ma chi mai sceglierà questa strada impopolare, che troverebbe dissenso in una società non avvezza agli stenti (viziata?), abituata a ragionare sul “carpe diem” e mai sul futuro a medio e lungo termine? Chi mai intraprenderà certe scelte, caratterizzate in pratica dalla consapevolezza quasi automatica di perdere il potere, dovendo così rinunciare ai privilegi acquisiti nel tempo? L’economia occidentale è nelle stesse condizioni di un malato grave, tenuto in vita da una macchina. Sarebbe possibile ipotizzare il tentativo di una terapia d’urto, ma non ne è certo il successo. E così, come certi medici disonesti messi nelle condizioni più inopportune, dalle stanze dei bottoni la scelta sarà quella di rifiutarsi di intervenire, ma, allo stesso tempo, anche di staccare i fili. Del resto il paziente, finché non ne viene dichiarato il decesso, continuerà a pagare la degenza.
Arduo per l’uomo della strada identificare tutte le concause che hanno portato a questo stato delle cose. C’è sicuramente stata una spinta “dall’alto”, favorita dal mancato esercizio degli organismi di controllo internazionale dei mercati (tipo il W.T.O., per intenderci), con la sempre maggiore commistione tra gli interessi di controllanti e controllati. Contemporaneamente, difficile non identificare anche una scarsa partecipazione “dal basso”: superate le guerre, terminate le spinte delle rivoluzioni culturali, messa in discussione la fede e la sua professione da parte dell’organismo che ne esercita il potere temporale, il concetto di “impegno” , nel senso di coscienza individuale applicata al sociale, è venuto meno. I mitici anni ottanta, con il loro edonismo e sfrenato individualismo, hanno prodotto solo il risultato di una diffusa e mal interpretata filosofia alla Voltaire di coltivare il proprio orticello, senza badare al deserto che nel frattempo si espandeva fuori dai propri cancelli.
Si vedrà come affronterà la generazione delle cadute questo momento storico.
O forse, semplicemente, si vedrà se lo affronterà: o se lascerà invece che ad affrontarlo sia ancora la generazione precedente (un errore imperdonabile, giacché non condivide evidentemente lo stesso orizzonte prospettico), o peggio lo lascerà vigliaccamente in eredità alla nostra discendenza (sempre se potrà davvero scaricare il barile).
Per il momento, sento solo sussurri che identificano il momento attuale così nefasto. Posso solo augurarmi di essere io troppo pessimista (una condizione d’animo che pur non mi ha mai appartenuto, anche grazie alla vita che è sempre stata generosa con me), e sbagliare valutazione. Lo scopriremo, se e quando i sussurri si trasformeranno in grida, rendendoci così consapevoli che potremmo avere atteso l’arrivo della tempesta con l’atteggiamento proprio degli struzzi.
Quel giorno, che in fondo è già oggi, saremo costretti a toglierci quell’etichetta di viziati dalla fronte, senza più smarrirci nella sterilità di identificarne le cause dell’attribuzione. E, soprattutto, ci dovremo sfilare di dosso la tentazione di praticare l’unica inutile attività esercitata oggi dal circo mediatico e, troppo spesso, anche dalla gente comune: quella della ricerca spasmodica, a destra come a sinistra, di colpevoli o salvatori.
Masonmerton(collaboratore)









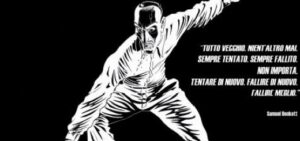

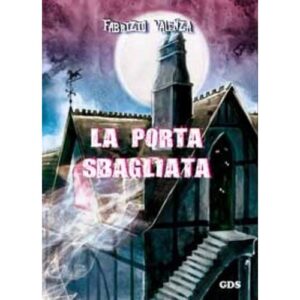

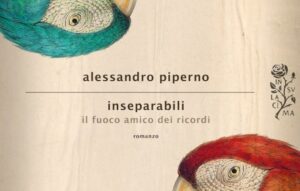
2 comments